Stefano Fontana
L’eredità di Francesco
Gli interventi sociali di papa Francesco sono stati indubbiamente molti, ma i criteri di giudizio sono stati evidentemente mondani, soprattutto perché sono venuti meno i presupposti filosofici e teologici della tradizione cattolica, il rapporto tra natura e soprannatura e tra ragione e fede.
Esaminando le trasformazioni intervenute in questi 12 anni non si può non notare che durante il pontificato di Francesco si è persa la traccia della Dottrina sociale della Chiesa (DSC). Non solo non si è più adoperata l’espressione, né i suoi principi e criteri per valutare i molti nuovi fenomeni sociali, ma soprattutto sono venuti meno i suoi presupposti filosofici e teologici, senza dei quali essa si riduce a moralismo sociale e a generico umanesimo solidaristico. Il quadro di riferimento di questi fondamenti aveva retto, pur con qualche difficoltà, fino a Benedetto XVI, poi molto è andato perduto e quanti avevano coltivato il loro impegno nella DSC sono stati duramente messi alla prova. Da un certo momento in poi quanto si diceva e faceva prima non è stato più possibile dirlo né farlo. Dall’oggi al domani un nuovo schema era stato imposto.
Il principale di questi presupposti di quadro è il corretto rapporto tra la natura e la soprannatura, quindi tra ragione (compresa la ragione politica) e la fede religiosa. Si sa che la teologia delle università pontificie non usa più queste parole dal sapore metafisico ormai sostituite dalla prospettiva storica ed esistenziale, molto più orizzontale. Senza di esse, però, diventa impossibile la DSC, vale a dire lo sguardo di Dio sulla comunità umana, con tutte le sue esigenze salvifiche, che incontra le verità della ragione politica, le rafforza e le purifica.
La DSC ha bisogno di fondarsi sulla Parola di Cristo salvatore ed anche sulla verità della ragione naturale che alla fine proviene da Cristo creatore. La DSC ha bisogno di fondarsi su un ordine naturale e finalistico, connaturato nella natura sociale dell’uomo e capace, nonostante la situazione decaduta successiva al peccato, di giungere ai preamboli della fede, per permettere alla Parola di esprimersi in linguaggio comprensibile.
In questo ordine naturale finalistico sono contenuti i principi della morale sociale e politica, che la rivelazione conferma e la Chiesa protegge, senza dei quali non c’è DSC, perché verrebbero meno il concetto del bene comune e il fondamento dell’autorità politica. Del diritto naturale e della morale naturale la DSC ha bisogno.
In questo pontificato, però, i concetti ora ricordati non sono stati più ripresi. Il diritto naturale e la morale naturale non sono più stati chiamati in causa. I principi non negoziabili, che promanano dalla legge naturale, sono stati negati e obliati. È stata proposta una Chiesa inclusiva di tutti i comportamenti, secondo cui c’è solo l’essere e non più il dover essere, dato che Dio ci amerebbe non solo così come siamo ma anche così come rimaniamo, una Chiesa che non giudica le vicende storiche ma si limita ad accompagnarle. Una Chiesa che fa riferimento solo alla misericordia trascurando la verità si scopre sfasata rispetto alle esigenze della DSC, che è giudizio sulla storia e sul mondo alla luce della ragione naturale e della rivelazione.
Questa assenza della prospettiva del diritto naturale si è evidenziata anche in documenti di natura non strettamente sociale o politica. La nuova interpretazione dell’adulterio in Amoris Laetitia non tiene conto che esso va contro il diritto naturale e non solo il diritto divino. La benedizione delle coppie di persone omosessuali in Fiducia supplicans dimentica che è la stessa ragione naturale, prima che le norme evangeliche, a dire che non si tratta nemmeno di coppie. Trascuratezze di questo genere nell’ordine della ragione naturale hanno ripercussioni sulla DSC, che fonda la società sulla famiglia e sul matrimonio. Le aperture al riconoscimento giuridico delle unioni civili anche omosessuali, espresse direttamente dallo stesso Francesco, gli incoraggiamenti a movimenti favorevoli al transgenderismo hanno indebolito, se non resa impossibile, la coerenza tra fede e politica su cui si regge la DSC. Mai come in questo pontificato i fedeli laici hanno sentito il disagio di non essere più guidati e formati organicamente nel loro impegno nel mondo.
Se prendiamo in esame gli interventi di Francesco su tematiche di morale sociale, ci si accorge che egli si è sempre rivolto a tutti, indifferentemente, e mai ai cattolici e ai credenti. I discorsi ai movimenti popolari di vario genere, gli interventi diretti alle fondazioni globaliste, i messaggi ai movimenti per i “nuovi diritti” … non hanno mai parlato di Cristo. Rivolti a tutti indifferentemente, con criterio estensivo ed inclusivo, quegli interventi si collocavano perciò ad un livello solo umano. Giovanni Paolo II scriveva nella Centesimus annus che la DSC è annuncio di Cristo nelle realtà temporali e che aveva come scopo la evangelizzazione, della quale era uno strumento. Niente di tutto questo nel pontificato di Francesco, durante il quale l’evangelizzazione è stata esclusa in quanto forma di proselitismo, e al cristiano è stato chiesto di occuparsi del povero ma non più di costruire la società, i cui criteri architettonici sono conservati nella DSC.
Nell’affrontare i principali processi in atto nelle nostre società, come il Covid, l’immigrazione, l’ambiente, l’unificazione europea, non sono mai stati adoperati i principi e i criteri della DSC. Si è invece preferito intervenire caso per caso, ponendo domande più che indicare risposte, favorendo un discernimento delle coscienze che senza dottrina si trova sperduto, proponendo la Chiesa come accompagnatrice e non più come guida. È successo così che, alla fine, sulle grandi tematiche sopra ricordate, la Chiesa è stata assente, finendo per appiattirsi sulle correnti più forti del globalismo imperante. E, per di più, felice di essere assente, considerando questo posizionamento come più “evangelico”.
Qualcuno potrebbe ricordarci che Francesco ha scritto anche due encicliche proposte e considerate a carattere sociale, la Laudato si’ (18 giugno 2015) e la Fratelli tutti (3 ottobre 2020). Con ciò, come si può dire che egli abbia trascurato la DSC? La Laudato si’ è dedicata ad un tema settoriale, quello ambientale, diversamente dalle precedenti encicliche; la sua stesura, per ammissione dello stesso Francesco, è dovuta a Leonardo Boff; gran parte del suo testo è occupato da luoghi comuni sull’ambientalismo cari alla stampa di regime; ci sono gravi concessioni alla visione dell’uomo come parte di una più ampia madre terra e a forme economiche, come la decrescita felice, già criticate da Benedetto XVI. A questa enciclica si deve il “delirio ecologista” di tante conferenze episcopali e comunità cristiane e il loro allineamento ai piani dei grandi del mondo a questo proposito. Quanto alla Fratelli tutti, l’enciclica pretendeva di fondare la fratellanza tra gli uomini non sulla comune natura umana frutto della creazione e sulla elezione a figli dal Padre, ma sull’essere “sulla stessa barca”, vale a dire su una solidarietà puramente esistenziale. Queste due encicliche non possono essere considerate in continuità con l’intera tradizione della DSC.

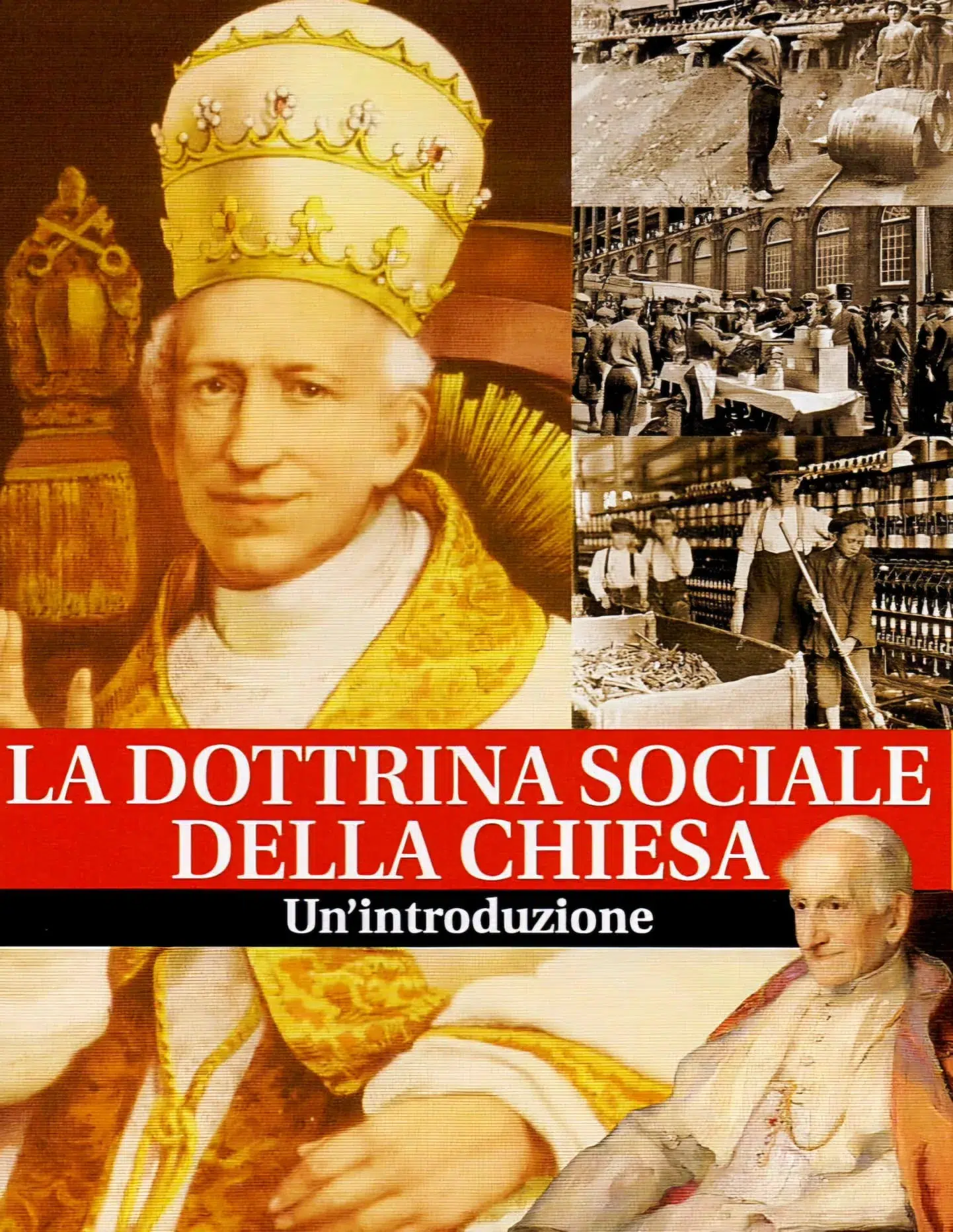





Lascia un commento